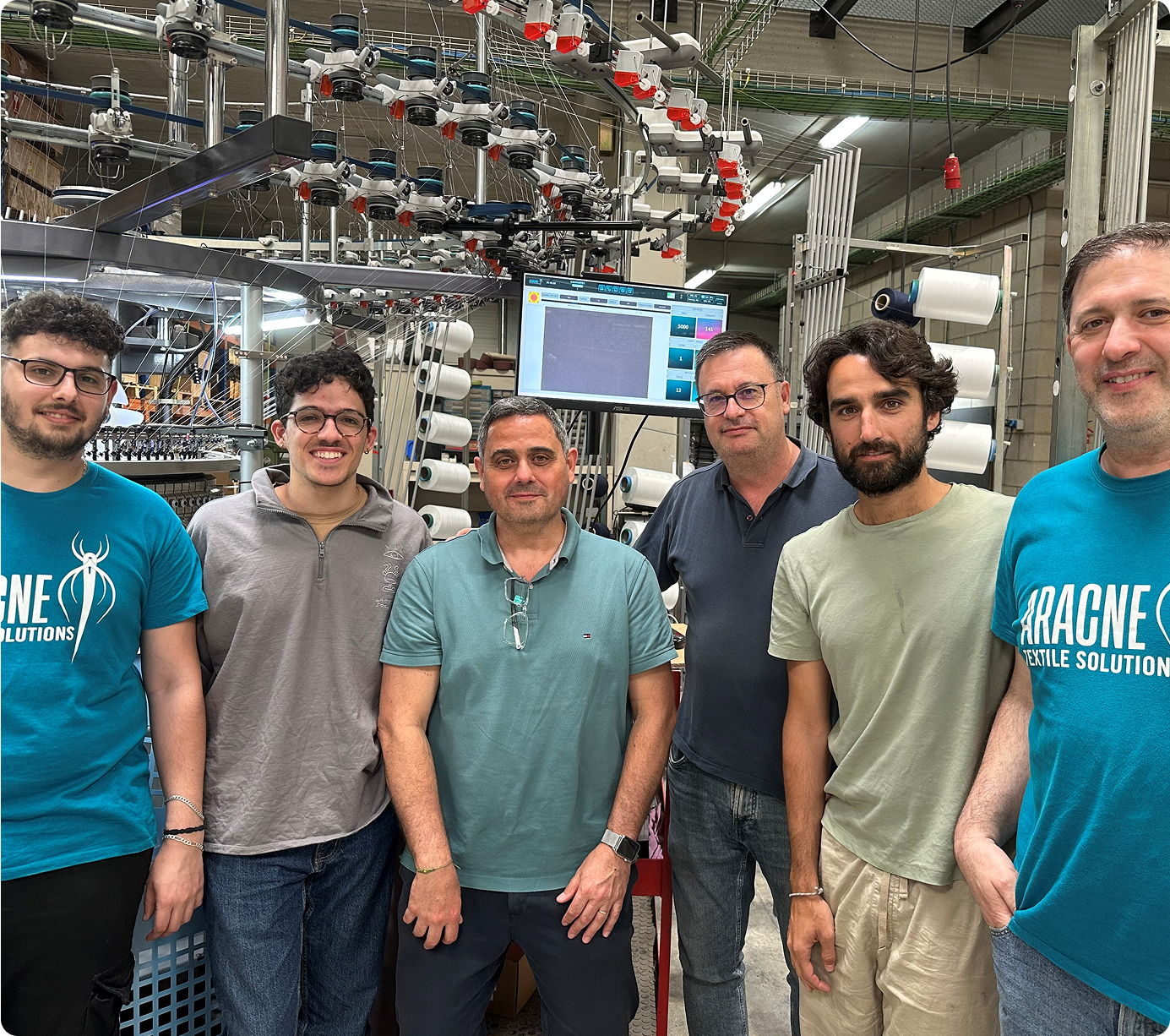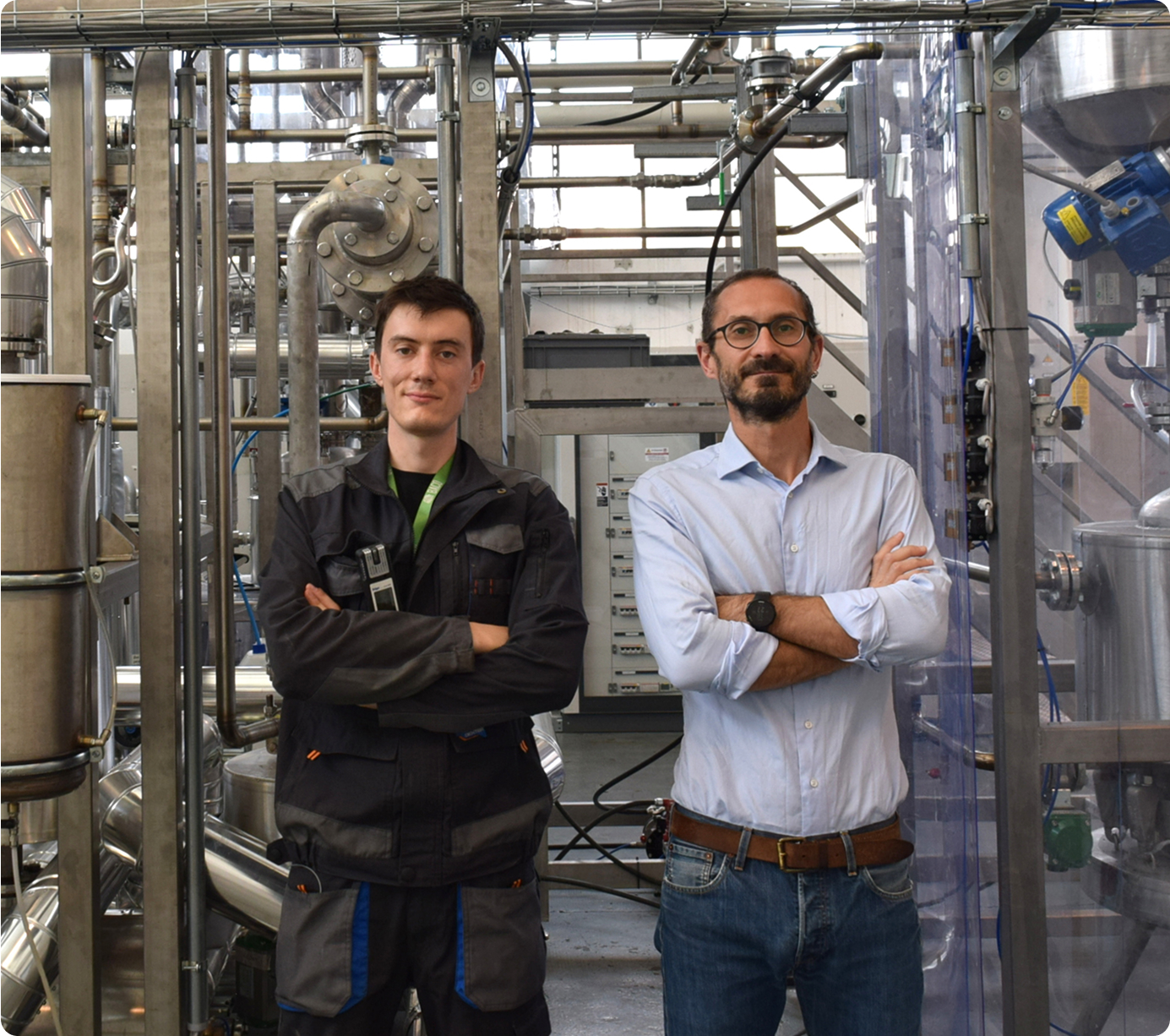Alleanze trasversali tra organizzazioni e startup innovative, transizione digitale preservando tradizione e identità, filiera interconessa e strategie evolute. Tutto questo e molto altro è Texploration, progetto di open innovation a livello nazionale e internazionale promosso e lanciato da MagnoLab, rete di aziende per l’innovazione della filiera tessile e realizzato da dpixel, la divisione di Fintech District che supporta la crescita delle startup e l’innovazione delle imprese favorendo le opportunità di business attraverso progetti di open innovation, e Sellalab in qualità di ecosystem partner.
In questo nuovo longform multimediale dedicato all’evoluzione del distretto tessile biellese e, in fondo, alle nuove reti di impresa si va dall’evoluzione delle monoculture industriali alla rinascita attraverso innovazione e collaborazione. Un viaggio anche geografico: da Eindhoven a Biella, la storia di territori che si reinventano intrecciando tradizione e futuro. Attraverso un unico filo rosso che lega competenze, persone e visione. Buona lettura!
***
Eindhoven era Philips, Philips era Eindhoven. Il legame indissolubile tra una delle più importanti fabbriche di elettrodomestici e la città olandese nacque agli albori del ’900, precisamente nel 1891, quando l’allora fabbrica di lampadine crebbe al punto da trasformare Eindhoven da piccolo villaggio agricolo nel sud dei Paesi Bassi a potenza industriale nazionale. Nel 1910 Philips era già la prima azienda olandese per dimensioni, importanza e organico, con oltre 2.000 lavoratori. Tutta l’urbanistica cittadina gravitava intorno agli stabilimenti: poiché il Comune, di indirizzo cattolico, non era disposto o in grado di aiutare la famiglia Philips (protestante-liberale), l'azienda costruì abitazioni, scuole, negozi, impianti sportivi e ricreativi (con teatro e cinema), sistemò spazi verdi, fornì servizi medici e fondò club sportivi. In questo intreccio tra industria e spazio urbano si può trovare un parallelismo con l’opera Ago, filo e nodo, l’opera monumentale di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen realizzata nel 1999 per il rinnovo della stazione ferroviaria Cadorna a Milano. Il gigantesco ago che trapassa la terra e si ricongiunge con il nodo colorato diventa simbolo della tradizione manifatturiera milanese e al tempo stesso della sua proiezione internazionale. Così come a Eindhoven la presenza di Philips cucì insieme fabbrica e comunità, definendo la fisionomia della città, a Milano l’ago e il filo intrecciano passato e futuro, ricordando come i territori sappiano riscrivere la propria identità attraverso segni condivisi che uniscono lavoro, cultura e innovazione globale.
Nel dopoguerra i lavoratori Philips erano oltre 400.000 e la città divenne centro mondiale dell’innovazione: negli stabilimenti di Eindhoven venne inventata la musicassetta (1963), il radioregistratore portatile (1966), la videocassetta (1972) e il compact disc (1982, con Sony).
Ma come in tutte le favole a un'armonia iniziale seguì una rottura dell’equilibrio narrativo: l’inizio della globalizzazione negli anni ‘70 e ‘80 e la concorrenza tecnologica dell’Asia fiaccarono la produzione elettronica olandese e la Philips iniziò a razionalizzare la produzione e delocalizzare gli stabilimenti. Nel 1990 la compagnia chiuse il bilancio con una perdita superiore ai 2 miliardi di dollari e ad ottobre dello stesso anno il nuovo CEO Jan Timmer fece scattare l’Operation Centurion: 50 mila licenziamenti. Nel 2001 il definitivo colpo con il trasferimento del quartier generale ad Amsterdam. La città subì un crollo occupazionale e identitario. Eindhoven, da locomotiva industriale, divenne una città-fantasma con enormi spazi industriali dismessi.
C’era solo un modo per risollevarsi: mantenere l’identità innovatrice e operosa della città ma indirizzare il percorso su altri binari. Nacque così un modello collaborativo università-governo e settore privato: quello che il sociologo Henry Etzkowitz nominerà “tripla elica” alle soglie del nuovo millennio. Nel 2005 nacque il marchio Brainport Eindhoven: un consorzio di università, imprese, enti pubblici e startup. Questo modello di collaborazione interdisciplinare permise di attrarre talenti, risorse finanziarie e tecnologie avanzate, generando un ciclo virtuoso che ha portato alla creazione di numerosi spin-off e startup ad alta intensità tecnologica. Grazie a questa efficace sinergia, Eindhoven è oggi responsabile di ben il 40% dei brevetti olandesi, consolidando il suo ruolo come polo d’innovazione tra i più prolifici e influenti d’Europa.
A distanza di 700 chilometri in linea d’aria c’è un altro centro, molto più piccolo che ha saputo cambiare pelle mantenendo fede alla tradizione industriale del proprio distretto. Se Eindhoven ha fatto da apripista a un modello virtuoso allora si può dire che Biella ha seguito questo sentiero incarnando un paradigma per tutto il territorio nazionale: negli scorsi due secoli Biella è stata la Manchester d’Italia, basata quasi esclusivamente sul distretto laniero, proprio come Eindhoven era cresciuta intorno a Philips. Biella ha una storia industriale che parte nel Medioevo e si sviluppa nell’Ottocento e Novecento. Durante il boom economico del secondo dopoguerra, Biella esportò in tutto il mondo tessuti di alta gamma destinati al lusso, consolidando una filiera verticale completa: dalla tosatura alla tessitura, fino alla confezione. Negli anni ‘80 e ‘90, la concorrenza asiatica, la delocalizzazione e l’emergere del fast fashion colpirono duramente il distretto biellese. Molti lanifici storici chiusero, i giovani migrarono verso Torino e Milano, e Biella entrò in una crisi identitaria ed economica che è riuscita a ribaltare negli ultimi vent’anni.
Biella ha infatti avviato un processo di rigenerazione industriale, puntando su sostenibilità, digitalizzazione e manifattura avanzata. Ex fabbriche come il Lanificio Maurizio Sella sono diventate incubatori di innovazione (Sellalab, Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto), e sono nate nuove iniziative come MagnoLab, un innovativo polo di ricerca e manifattura avanzata.
MagnoLab nasce dall’idea di sei imprenditori biellesi che, dopo viaggi in Silicon Valley, Svezia e Israele, hanno capito che in Italia mancava un centro capace di trasformare la ricerca tessile in applicazioni industriali. «Non volevamo creare un semplice laboratorio di ricerca, ma un luogo dove la tecnologia potesse fare il salto dalla fase sperimentale alla prototipia industriale», racconta Marco Vesipa project manager di Magnolab.